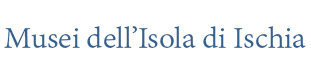L’informazione l’aveva appresa di recente e per la sua particolarità ne era rimasto molto colpito. Tanto da spingerlo a verificare se quella situazione così inconsueta potesse essere utilizzata in qualcuno degli esercizi di retorica che lo impegnavano e appassionavano non poco in quella fase dei suoi studi. Fu così che il giovane Marco decise di parlarne al suo maestro di latino e di retorica, il grande avvocato Frontone, che i contemporanei giudicavano secondo solo a Cicerone nell’arte dell’oratoria. Dunque, il discepolo gli sottopose il quesito in una delle lettere che i due si scambiavano regolarmente: come avrebbe potuto tornargli utile l’immagine di quella inconsueta realtà geografica da poco conosciuta per la quale nell’isola di Aenaria esiste un lago al cui interno si trova un isolotto, che è anch’esso abitato?
L’informazione l’aveva appresa di recente e per la sua particolarità ne era rimasto molto colpito. Tanto da spingerlo a verificare se quella situazione così inconsueta potesse essere utilizzata in qualcuno degli esercizi di retorica che lo impegnavano e appassionavano non poco in quella fase dei suoi studi. Fu così che il giovane Marco decise di parlarne al suo maestro di latino e di retorica, il grande avvocato Frontone, che i contemporanei giudicavano secondo solo a Cicerone nell’arte dell’oratoria. Dunque, il discepolo gli sottopose il quesito in una delle lettere che i due si scambiavano regolarmente: come avrebbe potuto tornargli utile l’immagine di quella inconsueta realtà geografica da poco conosciuta per la quale nell’isola di Aenaria esiste un lago al cui interno si trova un isolotto, che è anch’esso abitato?
La risposta di Frontone arrivò puntuale e perspicace: “Come l’isola grande ripara l’isolotto dalle tempeste marine, così l’imperatore padre tiene lontano dal principe ereditario le preoccupazioni del governo”. Una felice similitudine che, prendendo spunto dalla geografia, faceva diretto riferimento alla vita del discepolo. Perchè quel Marco non era un allievo qualunque. Nel 140 d.C., quando avvenne quello scambio di lettere, a soli diciotto anni, il giovane Marco Elio Aurelio Vero Cesare era già console, ma soprattutto era l’erede designato a succedere al padre adottivo Antonino Pio, da due anni imperatore di Roma.
Quell’isolotto situato all’interno dell’isola di Aenaria a cui fa un riferimento così esplicito il futuro imperatore Marco Aurelio, ovviamente esisteva davvero e si ergeva nell’ampio bacino lacustre che più tardi avrebbe preso il nome di Lago del Bagno. E doveva trattarsi di uno scoglio non tanto piccolo, se era in grado di ospitare perfino delle abitazioni. Del resto, in quell’epoca che precedeva la grande eruzione del Montagnone-Maschiatta, il lago, che confinava con il mare in corrispondenza della costa settentrionale dell’isola, doveva essere molto più grande di come in seguito ce ne avrebbero trasmesso la memoria l’iconografia e le fonti letterarie. E quindi anche l’isolotto poteva avere dimensioni maggiori. D’altra parte, quella di Marco Aurelio è la prima descrizione del lago sull’isola di Aenaria e dell’isola nell’isola. Con tanto di datazione precisa.
Altre notizie attendibili sull’isoletta nel lago risalgono a diversi secoli più tardi rispetto alla comunicazione di Marco Aurelio. Prima dell’anno Mille, comunque, quando sulla collina di San Pietro si era già insediata una comunità di monaci basiliani, che vi aveva edificato una badia. In quel periodo, sull’isola piccola non vi erano più le abitazioni dell’età romana, ma una chiesetta intitolata a San Nicola. Che vi sarebbe rimasta ancora per qualche secolo, visto il riferimento specifico che si trova nel “De’ remedi naturali” di Giulio Iasolino del 1588. Un piccolo edificio è visibile anche nel celebre dipinto di Philip Hackert che raffigura il Lago del Bagno nel 1792, quando, sulla collina retrostante il lago, il Casino del Protomedico Francesco Buonocore era già entrato nei possessi del re borbonico, inserita tra le Reali Delizie. Ma la struttura sull’isoletta non era più adibita a funzioni sacre, bensì, sconsacrata, si era trasformata da tempo in un deposito per i pescatori del lago.
Quella piccola isola nel lago, poi trasformato in porto nel 1854, è l’attuale Tondo, che dal 1990 con la costruzione del pontile ha perduto anche la poca evidenza che gli rimaneva, per immiserirsi in un un elemento anonimo del nuovo punto di attracco. L’inizio di una decadenza che ora rischia di tramutarsi in distruzione. Quello che non poterono eruzioni e disastri naturali in tanti secoli, riuscirà a noi in pochi anni, cancellando un luogo così affascinante e particolare della straordinaria storia della nostra isola?
C