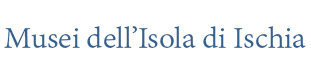Il restauro degli affreschi della Torre di Sant’Anna da parte dell’UNIVERSITA’ DI DRESDA è stato come aprire il vaso di Pandora. Al di là dell’enorme importanza del recupero delle testimonianze artistiche cinquecentesche e degli interventi funzionali a quell’obiettivo, la riscoperta degli strati delle pitture più antiche e il loro attento studio a 360 gradi sta consentendo di individuare e mettere insieme i tasselli della storia dei dipinti, del monumento isolano e di coloro che lo edificarono e lo abitarono nei secoli. Un approfondimento che va evidenziando man mano rapporti estremamente interessanti e imprevisti con la storia e con l’arte europee. A conferma di quanto Ischia nel suo passato non sia mai stata rimasta isolata ed esclusa rispetto ai grandi movimenti e rivolgimenti culturali del continente, per effetto della sua condizione di insularità, ma anzi ne sia stata sempre fortemente coinvolta e partecipe. Come è emerso nella CONFERENZA organizzata dal CIRCOLO SADOUL presso la Biblioteca Antoniana sabato scorso, per fare il punto sui risultati delle ricerche in corso sui dipinti della Torre sia a livello artistico che storico. Il quadro sapientemente descritto dall’avvocato ROSARIO DE LAURENTIIS ha offerto un’inaspettata varietà e ricchezza di spunti, rivelazioni, implicazioni e connessioni di ordine artistico, genealogico, storico che individuano nella Torre uno scrigno di conoscenze meritevole di ben altra considerazione e valorizzazione. Insomma, ce n’è (più che) abbastanza per non dover utilizzare ancora impropriamente il nome di Michelangelo e non dover propalare ulteriormente una storiella priva di qualunque fondamento, che serve solo ad oscurare una storia (vera) degna di questo nome dallo straordinario valore intrinseco e dall’indiscutibile fascino.
Il restauro degli affreschi della Torre di Sant’Anna da parte dell’UNIVERSITA’ DI DRESDA è stato come aprire il vaso di Pandora. Al di là dell’enorme importanza del recupero delle testimonianze artistiche cinquecentesche e degli interventi funzionali a quell’obiettivo, la riscoperta degli strati delle pitture più antiche e il loro attento studio a 360 gradi sta consentendo di individuare e mettere insieme i tasselli della storia dei dipinti, del monumento isolano e di coloro che lo edificarono e lo abitarono nei secoli. Un approfondimento che va evidenziando man mano rapporti estremamente interessanti e imprevisti con la storia e con l’arte europee. A conferma di quanto Ischia nel suo passato non sia mai stata rimasta isolata ed esclusa rispetto ai grandi movimenti e rivolgimenti culturali del continente, per effetto della sua condizione di insularità, ma anzi ne sia stata sempre fortemente coinvolta e partecipe. Come è emerso nella CONFERENZA organizzata dal CIRCOLO SADOUL presso la Biblioteca Antoniana sabato scorso, per fare il punto sui risultati delle ricerche in corso sui dipinti della Torre sia a livello artistico che storico. Il quadro sapientemente descritto dall’avvocato ROSARIO DE LAURENTIIS ha offerto un’inaspettata varietà e ricchezza di spunti, rivelazioni, implicazioni e connessioni di ordine artistico, genealogico, storico che individuano nella Torre uno scrigno di conoscenze meritevole di ben altra considerazione e valorizzazione. Insomma, ce n’è (più che) abbastanza per non dover utilizzare ancora impropriamente il nome di Michelangelo e non dover propalare ulteriormente una storiella priva di qualunque fondamento, che serve solo ad oscurare una storia (vera) degna di questo nome dallo straordinario valore intrinseco e dall’indiscutibile fascino.
 Il primo elemento di NOVITA’ che è stato appurato solo da qualche mese riguarda l’ISPIRAZIONE E L’ORIGINE DEI DIPINTI DELL’EDIFICIO QUATTROCENTESCO DI CARTAROMANA. Un tema, quello della loro attribuzione, che ovviamente è stato sempre in cima alla lista degli interrogativi a cui cercare di dare risposta, sfruttando al meglio le indicazioni e le tracce rivelate dai dipinti, con il procedere del loro accurato esame da parte dell’équipe dei restauratori tedeschi guidata dal professor THOMAS DANZL. Uno studio che per la prima volta, utilizzando tutti gli strumenti d’indagine disponibili, sta consentendo di conoscere le caratteristiche chimico-fisiche degli intonaci e dei pigmenti e le mutazioni indotte dal tempo, dalle sovrapposizioni di altri numerosi strati d’intonaco, dall’umidità e dalle condizioni ambientali. Ma anche di approfondire le tecniche pittoriche, che contengono indizi preziosi per risalire agli artisti artefici dell’opera. Ed è stato nel marzo scorso, proprio mentre stava riproducendo a mano libera su apposite tavole i disegni dei dipinti appena disvelati, che una delle giovani laureande impegnate nel restauro ha avuto una felice intuizione. In particolare, la ragazza stava disegnando i motivi a grottesca che sono risultati essere uno degli elementi salienti e più caratteristici delle decorazioni della Torre. E sono state le peculiarità delle figure e degli altri motivi decorativi a suggerirle un riferimento: JAN VREDEMAN DE VRIES, conosciuto anche come JOHAN FRISIO.
Il primo elemento di NOVITA’ che è stato appurato solo da qualche mese riguarda l’ISPIRAZIONE E L’ORIGINE DEI DIPINTI DELL’EDIFICIO QUATTROCENTESCO DI CARTAROMANA. Un tema, quello della loro attribuzione, che ovviamente è stato sempre in cima alla lista degli interrogativi a cui cercare di dare risposta, sfruttando al meglio le indicazioni e le tracce rivelate dai dipinti, con il procedere del loro accurato esame da parte dell’équipe dei restauratori tedeschi guidata dal professor THOMAS DANZL. Uno studio che per la prima volta, utilizzando tutti gli strumenti d’indagine disponibili, sta consentendo di conoscere le caratteristiche chimico-fisiche degli intonaci e dei pigmenti e le mutazioni indotte dal tempo, dalle sovrapposizioni di altri numerosi strati d’intonaco, dall’umidità e dalle condizioni ambientali. Ma anche di approfondire le tecniche pittoriche, che contengono indizi preziosi per risalire agli artisti artefici dell’opera. Ed è stato nel marzo scorso, proprio mentre stava riproducendo a mano libera su apposite tavole i disegni dei dipinti appena disvelati, che una delle giovani laureande impegnate nel restauro ha avuto una felice intuizione. In particolare, la ragazza stava disegnando i motivi a grottesca che sono risultati essere uno degli elementi salienti e più caratteristici delle decorazioni della Torre. E sono state le peculiarità delle figure e degli altri motivi decorativi a suggerirle un riferimento: JAN VREDEMAN DE VRIES, conosciuto anche come JOHAN FRISIO.

 Un nome, che dice poco ai non esperti, ma che per la giovane restauratrice e i suoi colleghi è decisamente familiare, giacchè si tratta di un grande dell’arte europea del XVI secolo. Fiammingo, De Vries fu architetto e ingegnere, suoi furono i progetti di strutture di difesa a Danzica e del palazzo imperiale e di alcune fontane a Praga e del municipio della città in cui risiedeva, Anversa. In tutti i luoghi dove lavorò, si distinse anche come pittore, lasciando dipinti importanti. Ma De Vries è anche molto conosciuto come incisore e come autore di ornamenti architettonici ispirati dall’arte rinascimentale italiani, comprese le grottesche, che anche a lui diventarono note tra gli artisti dell’Europa centrale. De Vries, infatti, è l’autore di varie raccolte di incisioni pubblicate da editori di Anversa e, in particolare, da HIERONYMUS COCK, il più grande editore d’arte del Nord Europa, incisore anch’egli e profondo conoscitore ed estimatore (come artista egli stesso) dell’arte rinascimentale italiana.
Un nome, che dice poco ai non esperti, ma che per la giovane restauratrice e i suoi colleghi è decisamente familiare, giacchè si tratta di un grande dell’arte europea del XVI secolo. Fiammingo, De Vries fu architetto e ingegnere, suoi furono i progetti di strutture di difesa a Danzica e del palazzo imperiale e di alcune fontane a Praga e del municipio della città in cui risiedeva, Anversa. In tutti i luoghi dove lavorò, si distinse anche come pittore, lasciando dipinti importanti. Ma De Vries è anche molto conosciuto come incisore e come autore di ornamenti architettonici ispirati dall’arte rinascimentale italiani, comprese le grottesche, che anche a lui diventarono note tra gli artisti dell’Europa centrale. De Vries, infatti, è l’autore di varie raccolte di incisioni pubblicate da editori di Anversa e, in particolare, da HIERONYMUS COCK, il più grande editore d’arte del Nord Europa, incisore anch’egli e profondo conoscitore ed estimatore (come artista egli stesso) dell’arte rinascimentale italiana.
Ma come può esservi un collegamento tra un artista del Centro e Nord Europa con la nostra Torre di S.Anna? Che c’entrano i dipinti di Cartaromana con le influenze fiamminghe che fin dal primo sopralluogo il professor Danzl vi aveva ravvisato?


 Il fatto è che De Vries, da Anversa, si era trasferito nel frattempo a Mechelen, dove rimase fino al 1564. A parte un periodo in cui fu costretto a rifugiarsi ad Aquisgrana, per sottrarsi all’Inquisizione, che lo aveva inserito da tempo nella lista nera. Non c’è da stupirsi, dunque, che tornato a Mechelen cercasse di ingraziarsi l’arcivescovo della sua città, dedicandogli una delle raccolte pubblicate con Cock. Senonchè, l’arcivescovo di allora era ANTOINE PERRENOT DE GRANVELLA, che qualche anno dopo, nel 1571, divenne viceré del Regno di Napoli. Dove portò sicuramente con sè anche l’opera di De Vries e la stima per lui e per altri artisti fiamminghi. E’ in quel contatto che gli studiosi hanno individuato l’origine dei motivi pittorici presenti nella Certosa di San Martino come all’Ospedale degli Incurabili. Insomma, l’opera di De Vries non solo era nota a Napoli, ma era stata anche motivo di ispirazione per opere d’arte realizzate in città. E da diversi secoli, ma in particolare in quel periodo, le correnti artistiche più in voga nella capitale finivano con il lasciare sempre tracce profonde anche sull’isola d’Ischia, grazie alla committenza dei nobili locali. Era accaduto in età angioina, accadde ancora in pieno Umanesimo e Rinascimento. Di sicuro i GUEVARA, che vivevano anche in città, scelsero quanto di meglio era disponibile a Napoli in quel momento a livello artistico per abbellire la loro magnifica dimora di vacanza affacciata sulla Città d’Ischia. E fu così che arrivarono sull’isola quei nuovi motivi tratti da De Vries, che a sua volta li aveva mutuati dalle rielaborazioni dei grandi artisti italiani del Rinascimento, in primis RAFFAELLO E PINTURICCHIO, che si erano ispirati ai dipinti della Domus Aurea di Nerone. Riscoperta a Roma proprio in quella straordinaria stagione dell’arte.
Il fatto è che De Vries, da Anversa, si era trasferito nel frattempo a Mechelen, dove rimase fino al 1564. A parte un periodo in cui fu costretto a rifugiarsi ad Aquisgrana, per sottrarsi all’Inquisizione, che lo aveva inserito da tempo nella lista nera. Non c’è da stupirsi, dunque, che tornato a Mechelen cercasse di ingraziarsi l’arcivescovo della sua città, dedicandogli una delle raccolte pubblicate con Cock. Senonchè, l’arcivescovo di allora era ANTOINE PERRENOT DE GRANVELLA, che qualche anno dopo, nel 1571, divenne viceré del Regno di Napoli. Dove portò sicuramente con sè anche l’opera di De Vries e la stima per lui e per altri artisti fiamminghi. E’ in quel contatto che gli studiosi hanno individuato l’origine dei motivi pittorici presenti nella Certosa di San Martino come all’Ospedale degli Incurabili. Insomma, l’opera di De Vries non solo era nota a Napoli, ma era stata anche motivo di ispirazione per opere d’arte realizzate in città. E da diversi secoli, ma in particolare in quel periodo, le correnti artistiche più in voga nella capitale finivano con il lasciare sempre tracce profonde anche sull’isola d’Ischia, grazie alla committenza dei nobili locali. Era accaduto in età angioina, accadde ancora in pieno Umanesimo e Rinascimento. Di sicuro i GUEVARA, che vivevano anche in città, scelsero quanto di meglio era disponibile a Napoli in quel momento a livello artistico per abbellire la loro magnifica dimora di vacanza affacciata sulla Città d’Ischia. E fu così che arrivarono sull’isola quei nuovi motivi tratti da De Vries, che a sua volta li aveva mutuati dalle rielaborazioni dei grandi artisti italiani del Rinascimento, in primis RAFFAELLO E PINTURICCHIO, che si erano ispirati ai dipinti della Domus Aurea di Nerone. Riscoperta a Roma proprio in quella straordinaria stagione dell’arte.