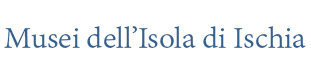“Il primo impulso ad interessarmi dell’archeologia di Ischia mi venne proprio dal libro testè ricordato del Beloch. Mio padre, che insegnava allora Zoologia e Anatomia comparata all’Università di Breslavia e soltanto da qualche anno aveva incominciato a costruirsi una casa sulla collina di S. Alessandro sopra il Porto d’Ischia, fin da allora aveva anche incominciato a raccogliere libri che trattano della nostra isola. Fortunatamente, nel deposito dell’editore presso il quale, proprio a Breslavia, era uscita la seconda edizione del libro “Campanien” del Beloch nel 1890, era rimasta ancora un’ultima copia invenduta che mio padre acquistò. Da tedesco coscienzioso e pignolo il Beloch ha voluto controllare di persona quanto aveva affermato Don Francesco De Siano. “Infatti – egli scrive – tutta la superficie di Monte di Vico è realmmente cosprasa di frammenti di tegole e di vasi antichi e dove si raschia il terreno con il bastone da passeggio vengono alla luce interi strati di cocci.”.
Questa frase eccitò vivamente la mia fantasia di studente di ginnasio e non vedevo l’ora della nostra prossima partenza per le vacanze estive ad Ischia. Finalmente il giorno venne che andai per la prima volta a cocci sul Monte di Vico. E ne raccolsi di tante specie diverse, neri e dipinti a righe rosse e brune, ed altri grezzi che però avevano la superficie ben levigata e lucida. Ma i cocci restavano ancora muti per me che non sapevo nulla della ceramica antica. Finchè non venne a farci visita un estroso barone siciliano, Otto De Fiore, ricercatore dalle attività multiformi, che si occupava ugualmente di Zoologia – ed era quindi collega di mio padre – come di Geologia e Archeologia. Così appresi che avevo trovato cocci greci di stile geometrico dell’VIII secolo a.C. e anche preistorici dell’età del bronzo, attici a vernice nera lucidissima del V secolo, campani a vernice nera più scadente del III secolo e imparai dal vivo le prime nozioni di ceramica antica.
Avevo trovato dunque le testimonianze che la città greca di Pithecusa fin dall’VIII secolo era situata sul Monte di Vico, cosa che già il Beloche avrebbe potuto accertare 50 anni prima, se avesse avuto un minimo di conoscenza di ceramica greca. Nacque così ad Ischia la mia passione per l’archeologia e quando venne il momento di iscrivermi all’Università avevo ormai deciso di abbandonare le orme paterne e di non studiare più biologia, come prima avevo pensato.
Naturalmente desideravo soprattutto di poter scavare la necropoli nella Valle di San Montano, dove c’era la speranza di poter trovare testimonianze assai più complete e consistenti dell’antica Pithecusa che non sul Monte di Vico, dove gli strati più antichi non soltanto dovevano essere stati già disturbati dalla vita della città nei secoli posteriori, ma tutti i livelli archeologici si presentavano rimaneggiati e compromessi dalle opere di terrazzamento per l’impianto dei vigneti. Dovevano passare ancora parecchi anni finchè potei iniziare finalmente i primi saggi a San Montano nella primavera del 1952, che portarono subito alla scoperta di tombe del VII e poi dell’VIII secolo a.C.”. (…)
Tratto da “La scoperta archeologica di Pithecusa”, comunicazione presentata nell’adunanza del Centro Studi sull’isola d’Ischia del 19 settembre 1980 – Ricerche contributi e memorie, vol.II.