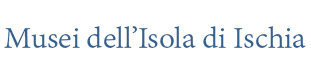Era il 2000 e quella crepa che attraversava l’arco l’aveva notata già da qualche tempo. Poi, dato che la lesione continuava ad allargarsi, DON PIETRO MONTI si era insospettito. Così si era deciso a mettere delle piccole spie per tenerla d’occhio. Poi, ne era comparsa un’altra, sempre sullo stesso arco e sempre abbastanza evidente. E le maioliche del pavimento del corridoio parallelo alla chiesa piccola di Santa Restituta avevano assunto un aspetto inconsueto, come se il cemento sottostante si fosse ritirato. Fu allora che si decise a chiamare i “mastri”. Ed il responso fu preciso: bisognava andare a controllare le fondamenta, scavare sotto.
Cosa ci fosse sotto, don Pietro lo sapeva. Sotto quell’arco lesionato c’era un cunicolo catacombale in opus lateritium, che immette nell’area degli scavi di epoca paleocristiana, per l’esattezza lí dov’é stata rinvenuta la navata destra della prima Basilica, edificata, a sua volta, sopra un tempio ed una palestra di etá romana. Andando a verificare con gli operai, apparve chiaro a questi che per restituire stabilitá alla struttura sovrastante, bisognava verificare cosa ci fosse al di lá della parete sinistra di quel cunicolo. Perciò si decise di procedere, smontando il muro pietra per pietra, con grande circospezione e delicatezza data la particolaritá del luogo. Ma don Pietro non poteva immaginare ciò che ancora una volta gli stava per svelare il sottosuolo della chiesa.
Quando i mattoni del muro si trovarono tutti accatastati sull’altro lato del cunicolo, don Pietro poté rendersi pienamente conto del valore della sua ultima scoperta archeologica: erano lí, davanti a lui, TRE TOMBE PALEOCRISTIANE, sistemate su due livelli corrispondenti ad altrettanti periodi storici, con corredo di frammenti di piccoli oggetti anch’essi molto interessanti. In basso, due tombe a cappuccina, realizzate con due file di grandi tegoli di terracotta sistemati a schiena d’asino, chiuse nella parte superiore da una fila di embrici. Le piú antiche del gruppo, databili intorno alla fine del IV secolo dopo Cristo. Sopra furono ritrovate due lucerne di terracotta rossa, di provenienza africana, come altre già tornate alla luce presso tombe coeve”. Al di sopra, separata dalle altre da uno strato di terra di una trentina di centimetri, la terza tomba, dalla forma a cassa, realizzata sempre con tegoli di terracotta. Più tarda, del V secolo. Sopra di essa dei frammenti di vetro rivelavano una frequentazione regolare da chi andava a pregare e a rendere omaggio a questi defunti.
Si trattava di sepolcri particolari. Proprio la loro inconsueta collocazione aveva suggerito a don Pietro che potessero ospitare sacerdoti e presbiteri. Per questo don Pietro lo definì “SACELLUM”. Da tempo, del resto, lo cercava, dopo aver riscoperto il cimitero paleocristiano dei fedeli, collocato fuori dalla basilica. Non fu semplice portare avanti quello scavo, mettendo in sicurezza le strutture sovrastanti. A dare una mano al rettore di Santa Restituta in quell’occasione fa anche PEPPINO SIMONELLI, uno dei due fidi collaboratori di BUCHNER negli scavi di San Montano e nel recupero, tra l’altro, della Coppa di Nestore.
Al di lá del valore dell’identificazione del “cimitero del clero”, quella scoperta si rivelò subito di straordinario valore. Per i reperti rinvenuti, innanzitutto. A cominciare dai grossi tegoli, realizzati con l’argilla locale di colore molto chiaro. Simili a quelli già riemersi dalle altre tombe del cimitero paleocristiano del IV-VI secolo. Una testimonianza di come in quel periodo fosse ripresa sull’isola un’attivitá figulina su larga scala, dopo la brusca interruzione seguita alla distruzione di Pithecusa ad opera di Silla nel I secolo a.C.. E molti tegoli recavano anche delle lettere graffite, corrispondenti ad una sorta di marchi di fabbrica.