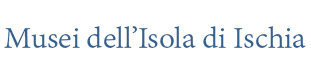Domani, il convegno organizzato per ricordare la figura di Don Pietro Monti nel centenario della nascita – che si terrà a Lacco Ameno, presso l’Hotel Terme di Augusto dalle ore 17.00 – avrà tra i relatori sia il professor Heylmeier che la professoressa Gloria Olcese, protagonisti nei primi anni 2000 di una importantissima ricerca sulla produzione della ceramica pithecusana che ebbe come punto di riferimento proprio il prete-archeologo ischitano e le sue scoperte. Questo articolo fu pubblicato all’inizio del 2001 su un quotidiano tedesco di notevole tiratura il “TAGESPIEGEL”, nella pagina della Cultura, e rappresentò un significativo contributo alla divulgazione della realtà archeologica portata alla luce da don Pietro Monti sulla nostra isola. La traduzione dal tedesco, pubblicata sull’inserto Cultura de “Il Golfo” il 7 febbraio 2001, fu curata da PIETRO FERRANDINO.
DON PIETRO SVELA L’ANTICHITA’ . RICERCA NEI MUSEI: LE FABBRICHE DI TERRACOTTA SULL’ISOLA D’ISCHIA di Wolfgang Lehmann
Per primi furono gli antichi Greci a giungere ad Ischia. Ma non vi arrivarono così come lo fanno oggi, come turisti, i tedeschi e gli altri europei del nord, bensì come cercatori di nuove terre. La grecia era diventata troppo piccola per loro, così nell’VIII secolo a.C. si riversarono verso occidente come colonizzatori. L’isola verdeggiante di vegetazione nel Mar Tirreno dovette sembrare accessibile ai coloni delle due città vicine di Calcide ed Eretria sull’isola di Eubea. In particolare, quel Monte vico che sporgeva nel mare presso Lacco ameno ricordava molto bene la loro patria. Così Ischia divenne il “palcoscenico di un avvenimento di importanza storica mondiale”, come Paul Buchner scrive nel suo libro “Gast auf Ischia”. Laddove oggi i bagni termali del Negombo offrono ai loro ospiti moderni impianti, si presentò ai navigatori dell’antichità un sicuro luogo di approdo. Qui i greci fondarono quello che a noi è noto come il più antico insediamento di nome Pithecussai. Essi si stabilirono qui ancor prima che sul continente, a Cuma, come riferisce Livio. Essi trovarono tutto ciò che serviva alla loro sussistenza: acqua, un hinterland fertile e soprattutto un porto sicuro o, più precisamente un luogo di approdo. A Ischia, essi trovarono anche l’argilla per le loro ceramiche. E il fatto che essi la producessero non esclusivamente per le loro necessità, ma che commerciassero con essa, è attestato dai bolli stampati sulle anfore, che sono state trovate in altre regioni del Mediterraneo, fin verso la Francia meridionale. Dei sommozzatori scoprirono i recipienti addirittura ancora pieni di vino a bordo di una nave affondata presso Lipari. RIPRODOTTE SCENE DI NAUFRAGIO
Evidentemente Pithecussai era un importante centro commerciale. Qui furono trovati, per lo più come oggetti funerari, manufatti provenienti dalla Grecia e dall’Asia Minore. Tra i prodotti locali, è rimarchevole un vaso con la rappresentazione del naufragio: uomini in balia delle onde annaspano tra pesci e navi capovolte. Il vaso può essere visto nella Villa Arbusto, il museo “ufficiale” di Lacco Ameno, aperto dopo lunga attesa l’anno scorso. Nell’indagine sui luoghi di produzione della ceramica sono impegnati anche la LIBERA UNIVERSITA’ DI BERLINO e la raccolta di antichità berlinesi del Ministero della cultura prussiano. Sotto la CHIESA DI SANTA RESTITUTA a Lacco Ameno si trovano sette antiche fornaci, portate alla luce nei decenni passati dal parroco della chiesa DON PIETRO MONTI. Dal 1947, egli è rettore del santuario, luogo di culto della Santa Restituta, secondo la leggenda, una martire della Tunisia il cui cadavere, depositato su una barca, fu spinto a riva. La santa viene venerata ancora oggi ad Ischia per i suoi miracoli.
Membro di un’antica famiglia, don Pietro si è interessato subito della storia della sua isola. Egli ha raccolto reperti archeologici ed è divenuto noto per la sua passione, e gli abitanti gli hanno portato -di propria iniziativa – i loro reperti da un po’ tutta l’isola. Egli ha raccolto i suoi studi in un’ampia opera storica. Ed ha continuato a scavare.
In verità, la competenza per gli scavi archeologici è dello Stato italiano, ma in base al Concordato con il Vaticano il terreno della chiesa appartiene a quest’ultima. Così, don Pietro potè scendere nelle profondità sotto la sua chiesa ed iniziò ad operare già negli anni Cinquanta.
Il suo museo, che ha allestito con i suoi fondi archeologici, è noto ai turisti interessati. Adesso, il suo lavoro viene puntellato anche dal punto di vista scientifico. WOLF DIETER HEILMEYER, Direttore della raccolta di antichità del Museo statale prussiano, studierà e pubblicherà il lavoro del collega amatore e, assieme con GLORIA OLCESE, un’esperta di archeometria della Libera università, analizzerà le fabbriche dei vasi.
Il progetto viene sostenuto dalla FONDAZIONE THYESSEN. Lo studio delle fabbriche figuline e i relativi metodi di produzione è lo scopo di questo PROGETTO DI RICERCA “ISCHIA” dai molteplici aspetti, al quale appartiene non solo la descrizione del museo e del lavoro di don Pietro, ma anche la leggenda della Santa Restituta. La leggenda della figura di una santa venuta dal mare era diffusa già nell’antichità, ad esempio sull’isola greca di Samo. Lì era giunta a riva una statua d’oro della dea Era, destando stupore. Anche ad egina, nel golfo salonico, giunse – sempre dal mare – una dea miracolosa, di epoca posteriore, Apaia, divinità del tempio.
Per i suoi temi, l’indagine sulla produzione di ceramica si associa alla ricerca degli antichi metodi di produzione del museo berlinese. Fino ad ora sono stati indagati i procedimenti della fusione del bronzo. Già è disponibile la copia del “fanciullo che prega”, come la riproduzione della fornace sulla coppa da vino, per potere ricostruire gli ambienti di antiche officine. E l’Istituto per l’esame e la ricerca di materiali ha intrapreso un’analisi della fusione di statue di bronzo. Fino ad ora, nelle due campagne di scavi, gli scienziati sono risaliti fino al III secolo prima di Cristo, l’epoca dell’Ellenismo. Una precisa determinazione cronologica verrà fornita da indagini di tipo naturalistico-scientifico. In ogni caso, le fornaci rinvenute risalgono all’epoca pre-romana. Questo è certo, perché le fornaci si trovano al di sotto di strati più recenti.
Sotto l’attuale chiesa di Santa Restituta si trovava una Basilica pre-cristiana con cimitero, al di sotto della quale erano situati un cimitero romano e una costruzione, sempre romana, che don Pietro riteneva fosse un tempio. Solo dopo si è arrivati alle fornaci greche. Esse erano dunque già lì, quando i romani si insediarono sull’isola nel II secolo prima di cristo, e presero a seppellirvi i loro morti.
Fino ad ora sono state RITROVATE SETTE FORNACI, che possono essere assegnate a quattro diverse destinazioni. Ognuna di esse si sarebbe conservata così bene, al punto tale di poter essere ricostruita.
“UNA COSA UNICA LA MONDO!”, secondo Heilmeyer. Infatti, di norma le fornaci avrebbero dovuto essere distrutte quando la ceramica era cotta.
Per questo motivi gli archeologi ne sanno molto di meno di quanto si pensi. Del celebre “Kerameikos”, il quartiere figulino di Atene, non è rimasto che il nome. Lo scavo fatto in quella zona evidenzia in sostanza un cimitero. Le fornaci ischitane riappariranno in ogni caso in una ricostruzione grafica. Forse, gli scienziati potrebbero anche riprodurne una, ma questo sarebbe compito dell’archeologia sperimentale.
QUANDO VENNERO PRODOTTI I PEZZI?
L’indagine sulle officine figuline ad Ischia persegue due scopi: da una parte, ricavare la tipologia delle fornaci per l’argilla e, dall’altra, capire dove e quando la ceramica ritrovata al loro interno e nei loro pressi fu prodotta. Un compito per l’ARCHEOMETRIA, la quale include metodi naturalistico-scientifici nelle ricerche archeologiche. Dal 1980 circa gli archeologi si interessano, in base ai tipi del secolo XIX e in base alla determinazione degli stili del XX secolo, anche dei modi di produzione nell’antichità. Nel caso del “PROGETTO ISCHIA” vengono utilizzati due metodi di indagine archeometrica: l’analisi della termoluminescenza (TI) e l’analisi della fluorescenza Rontgen (Rfa).
Nel caso della prima, viene misurato ciò che rimane della quantità di “calore” immagazzinato all’atto della cottura, in un pezzo di ceramica oppure nella stessa fornace, “calore” che nel corso dei secoli decresce progressivamente. Con il secondo procedimento si può stabilire la composizione chimica della ceramica. Per ottenere dei risultati, c’è bisogno di un gruppo di referenze la cui origine sia ben chiara. Il confronto della composizione chimica conduce poi al riconoscimento che si prefigge di ottenere. Indicazioni sull’età delle fornaci e sull’origine dei pezzi ivi cotti possono venire da reperti bruciati, trovati nei pressi. Queste parti probabilmente furono abbandonate lì e possono essere utilizzate dagli archeometri come “fossili”, in grado di fornire preziose indicazioni. Infatti, se ad uno di questi corrisponde un altro pezzo, si potrà affermare che la sua materia prima proviene da Pithecussai.