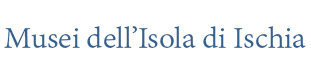Home
Cultura I putti ottocenteschi del Soccorso appena recuperati da un sapiente restauro
I putti ottocenteschi del Soccorso appena recuperati da un sapiente restauro
Posted about
10 anni ago |
 GINA MENEGAZZI
GINA MENEGAZZI
Un altro tassello della storia dell’arte religiosa ischitana è stato reso di nuovo fruibile a chi, fedele o semplice turista, si reca a visitare la meravigliosa chiesa del Soccorso, a Forio.
Sabato 28 maggio presso la chiesa stessa è stato presentato il restauro dei putti di cartapesta della cappella del Crocifisso, curato dalla restauratrice GIANNA IOZZI con la supervisione della dottoressa GINA CARLA ASCIONE, storico dell’arte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli. Ed è stata quest’ultima che, dopo le parole di saluto di DON EMANUEL MONTE, ha introdotto con la sua solita chiarezza queste opere di cartapesta, inquadrandole nel flusso della produzione del genere in Italia e nel mondo.
L’uso della cartapesta è di origine antichissima. I Greci già nel secolo IV a.C. utilizzano la fibra di lino – una delle sostanze con cui si fabbrica la carta –, amalgamandola a stucco e colore per realizzare maschere teatrali o votive, da appendere nei boschi sacri. L’invenzione del composto per produrre la carta, tuttavia, è merito dei Cinesi, cui si deve anche l’idea di cominciare a sfruttare tale materiale, intorno all’anno 100 d.C., per produrre oggetti d’uso comune come scodelle e cofanetti, che saranno persino impermeabilizzati, e in seguito, per creare opere d’arte.
Nel mondo occidentale la carta pista viene citata per la prima volta da Giorgio Vasari, nella Vita di Domenico Beccafumi, dove racconta che Jacopo della Quercia, scultore, iniziò a diciannove anni realizzando a Siena, su ordine del Comune, una statua equestre per le esequie del capitano Giovanni d’Azzo Ubaldini. L’artista, incalzato dalla necessità di eseguire in poco tempo una scultura commemorativa monumentale, modellò uno scheletro di legno, fasciandolo poi con fieno e stoppa, terra e colla, con una tecnica di sua invenzione. Si era sul finire del XIV secolo, e da Siena la tecnica si diffuse in tutta la Toscana. A Firenze Donatello, Antonio Rossellino, Benedetto da Maiano, Desiderio da Settignano fecero uso dell’impasto di carta per creare copie da prototipi eseguiti da loro stessi in materiali più nobili. La tecnica venne successivamente diffusa, ad opera degli stessi scultori, nel Veneto, in Umbria e nelle Marche. Jacopo Sansovino, per primo, eseguì opere in cartapesta come forme autonome d’arte, raggiungendo risultati d’altissimo valore.
L’età barocca vede la nascita del mestiere del “cartapestaio” e in Emilia aprono varie botteghe in cui artisti tra i più noti realizzano statue devozionali. Curioso è il caso dello scultore Zamaretta che realizza un crocefisso per la chiesa di Santa Maria dei Servi a Bologna, modellandolo su uno del Gianbologna e realizzandolo con un pesto di carte da gioco, raccolte durante una compagna moralizzatrice contro il gioco intrapresa da un frate predicatore nel 1551.
A Napoli la tecnica si sviluppò soprattutto all’inizio del Settecento, a opera di Domenico Punziano e seguaci, e da qui si diffuse in Sicilia e in Puglia, in particolare nella città di Lecce. La cartapesta così divenne rapidamente di moda, grazie anche alla sua leggerezza e facilità di lavorazione e portò alla creazione di bambole, cavalli a dondolo e altri giocattoli, nonché di soffitti, decorazioni e scenografie teatrali, e di un gran numero di statue di madonne e di santi.
Al campo devozionale appartengono i quindici piccoli Angeli con simboli della Passione, che decorano l’arco d’ingresso della cappella del Crocifisso nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Forio, qui posti, verosimilmente, nel 1837, quando un certo CRISTOFARO CALISI, in segno di venerazione nei confronti del Crocifisso cinquecentesco conservato nella chiesa, fece realizzare il cancello di ferro e la decorazione a finti marmi nella parte interna della cappella.
Intimamente legati a quel Crocifisso, anche se di epoca posteriore, i quindici angioletti si affollano fitti sull’arco d’ingresso alla cappella; i sei più in alto recano gli strumenti della Passione: i chiodi, il martello, la lancia, la croce, la corona di spine, le catene . Almeno tre le diverse tipologie, ricavate da altrettanti modelli in argilla, anche se in ciascun esemplare vi sono piccole varianti nelle dimensioni complessive, nell’espressione dei volti, nel colore dei capelli, nella posizione delle braccia e delle gambe. Sono tutti cinti da una fascia di colore diverso, dal verde al rosso passando per il bianco, il giallo e il blu, per dare ancora più movimento.
Il loro restauro, fortemente voluto da DON PASQUALE MATTERA, rettore della chiesa, che si sta adoperando per il graduale recupero di quest’ultima e che ha persino promosso una sottoscrizione “Soccorri il Soccorso – Adotta un Angelo” per raccogliere i fondi necessari al lavoro, ha impegnato notevolmente la restauratrice Gianna Iozzi, dato che, come ci è stato mostrato con una serie di diapositive, il degrado dei putti era molto elevato. Spaccature, sfondamenti, bruciature, parti mancanti – soprattutto le dita di mani e piedi -, materiale vario quale nastro adesivo, colla vinilica insetti e loro nidi – in particolare la vespa vasaia – avevano ridotto proprio male gli angioletti che, pur se non di particolare qualità artistica, meritavano un lavoro di recupero. Sono stati quindi smontati e studiati al microscopio, che ha rivelato almeno tre strati di carta, interposti con strati di differenti materiali, quali la fibra di lino, la fibra di cellulosa e la fibra di legno. Lasciati asciugare all’aria dall’umidità accumulatasi nel tempo, ne è poi stato asportato tutto il materiale incongruo, compresi cera di candela e pezzi di ferro. Si è poi provveduto alla ricostruzione delle parti mancanti, eseguita con cellulosa dalla consistenza lanuginosa addizionata con acqua calda. Stuccatura, pulitura, ritocco pittorico e verniciatura finale hanno infine permesso di ricollocare i putti nel posto a loro destinato, a fare da corona e da invito al Crocifisso cinquecentesco “venuto dal mare”.
 GINA MENEGAZZI
GINA MENEGAZZI