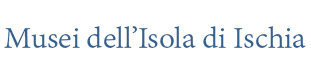Con la (ri)scoperta di Aenaria, un altro periodo fondamentale del passato remoto dell’isola comincia ad essere messo meglio a fuoco dagli esperti. Merito delle campagne di scavo che si sono susseguite ogni anno, in primavera e in autunno, dal 2010 fino a qualche settimana fa nello specchio acqueo della baia di Cartaromana. Altri tasselli che vanno a ricomporre il grande mosaico della storia ischitana, colmando vuoti, confermando o smentendo ipotesi, chiarendo dubbi, fornendo risposte. E anche riequilibrando in qualche modo l’enorme divario esistente tra il livello di conoscenza e di recupero di testimonianze raggiunto nel ’900 rispetto all’epoca greca, grazie all’opera di Giorgio Buchner nell’esplorazione dei siti di Pithecusa, e quello riferibile invece all’epoca romana. Conseguenza soprattutto delle caratteristiche naturali dell’isola che, troppo spesso sconvolta da eruzioni e cataclismi in quella fase della sua complessa storia geologica, non aveva conosciuto allora un periodo di grande fulgore.
Con la (ri)scoperta di Aenaria, un altro periodo fondamentale del passato remoto dell’isola comincia ad essere messo meglio a fuoco dagli esperti. Merito delle campagne di scavo che si sono susseguite ogni anno, in primavera e in autunno, dal 2010 fino a qualche settimana fa nello specchio acqueo della baia di Cartaromana. Altri tasselli che vanno a ricomporre il grande mosaico della storia ischitana, colmando vuoti, confermando o smentendo ipotesi, chiarendo dubbi, fornendo risposte. E anche riequilibrando in qualche modo l’enorme divario esistente tra il livello di conoscenza e di recupero di testimonianze raggiunto nel ’900 rispetto all’epoca greca, grazie all’opera di Giorgio Buchner nell’esplorazione dei siti di Pithecusa, e quello riferibile invece all’epoca romana. Conseguenza soprattutto delle caratteristiche naturali dell’isola che, troppo spesso sconvolta da eruzioni e cataclismi in quella fase della sua complessa storia geologica, non aveva conosciuto allora un periodo di grande fulgore.
Senonchè, tra le tesi da riconsiderare e ridefinire, alla luce di quanto sta emergendo nel meraviglioso tratto di mare sotto il Castello, c’è probabilmente anche quella del ruolo di secondo piano (se non peggio) che finora era stato assegnato a Ischia rispetto ad altre località della Campania felix - a cominciare da Capri - in cui le evidenze di una importante presenza romana sono più diffuse, imponenti e soprattutto note da più lungo tempo. Le novità che arrivano ora da Aenaria sono in grado di rimettere in discussione parecchie delle “certezze” che si ritenevano acquisite. E, d’altra parte, ancora negli anni ’30 del secolo scorso un grande archeologo come Amedeo Maiuri scriveva che Ischia dal punto di vista archeologico era “ignota”. Quello che è accaduto dopo, a partire dai primi anni ’50, ci ha restituito invece un quadro completamente diverso, incoronando addirittura Pithecusa come l’alba della Magna Grecia.
L’esplorazione dei fondali della baia condotta dai giovani ricercatori di “Marina di Sant’Anna”, guidati dall’archeologa subacquea Alessandra Benini, con la supervisione della Sovrintendenza archeologica speciale di Napoli e Pompei, ha consentito di approfondire notevolmente i risultati delle indagini condotte quarant’anni fa. E di portare avanti uno scavo molto accurato, i cui rilievi e dati, una volta studiati con cura, potranno aggiungere molto altro rispetto alle informazioni già raccolte.
LE SCOPERTE DEGLI ANNI SETTANTA
In passato, sia a terra che a mare, Aenaria aveva restituito di sè molti reperti ceramici, per lo più di uso comune, che facevano pensare all’esistenza di un grosso centro residenziale, che si estendeva dalla costa – la parte oggi sommersa – alle colline retrostanti, fino per intenderci a San Michele. Non erano mancati neppure rinvenimenti di tratti di mura, a terra, durante lavori che poi hanno completamente distrutto o comunque coperto quanto era riemerso da sotto terra. E lo stesso a mare, dove però non c’erano stati mai nè il tempo nè la possibilità di seguire le tracce già individuate. Si era ipotizzata già la presenza di un’area portuale piuttosto vasta e si parlava di un’antica strada che sarebbe arrivata fino al punto in cui ora sorge la chiesetta di Sant’Anna. Ma soprattutto la scoperta di quantità significative di metalli grezzi, in particolare di galena, ma anche di lingotti di piombo come di manufatti di altri metalli, unitamente a vari residui di fusioni erano stati collegati ad un’importante attività di lavorazione dei metalli. A comprovare la tesi di una fiorente industria dei metalli, le “firme” su diversi lingotti di grosse dimensioni di Gneo Atellio e di suo figlio Miserino. Ciò che è stato interpretato come la dimostrazione dell’esistenza ad Aenaria di una “plumbaria”, attiva a cavallo tra il I secolo a.C e il I d.C., riconducibile direttamente ad una famiglia nota, gli Atellii, che esercitavano quell’attività anche in Spagna, a Carthago Nova, l’odierna Cartagena.
LE SCOPERTE DI OGGI: LE VILLE, LA STRADA, IL GRANDE PORTO COMMERCIALE
Le ricerche compiute in questi ultimi anni, esplorando in modo sistematico i fondali con l’ausilio della sorbona, oltre a grandi quantitativi di ceramiche di uso domestico e di anfore, riconducibili a dei magazzini per lo stoccaggio delle merci, hanno permesso di individuare tratti di mura di abitazioni, anche di prestigio. Una delle ville, per esempio, era collegata alla sua area esterna da un tunnel di una decina di metri che è stato ritrovato nell’area degli Scogli di Sant’Anna. Uno di essi nasconde al suo interno una grotta utilizzata come ninfeo e nella parete di fondo è scavata una nicchia. Ma ci sarà ancora bisogno di approfondire la conoscenza di quel luogo, anche per la massiccia presenza di detriti marini.
Sul fondale, il selciato di un’antica strada ne ha confermato in pieno l’esistenza e anche la lunghezza non trascurabile. Ma la scoperta più importante e preziosa riguarda le strutture del porto di Aenaria, un grande porto commerciale, identificato a mare, proprio davanti alla chiesetta. Sotto la prateria di Posidonia e la sabbia sono venuti alle luce i resti delle banchine. Ma, cosa ancora più rara e preziosa, anche le tavole lignee della cassaforma usata solitamente dai Romani per costruire opere in mare. La sabbia ha preservato nei secoli il legno, restituendolo in buone condizioni agli esploratori di oggi. E per lo stesso motivo sono stati ritrovati nei pressi del porto anche resti di navi, conseguenze di naufragi tutt’altro che rari nell’antichità.
Ciò che non è stato ancora scoperto è il sito della plumbaria: ci sono le scorte dei metalli, ci sono gli oggetti finiti, ci sono le scorie delle lavorazioni, ma per ora manca il luogo dove l’attività si svolgeva. Attività di tale rilevanza che ormai è data per certa l’origine del nome Aenaria proprio da “aenum”, metallo. E non dal nome di Enea, come pure Plinio aveva sostenuto.
Altro “mistero” in via di chiarimento è quello della causa che portò all’abbandono della città tra il 130 e il 150 d.C. Tante le ipotesi, compresa quella del bradisismo, che interessa quella zona come anche il tratto costiero dall’altra parte del ponte Aragonese, davanti all’abitato di Ischia Ponte. Tutti gli indizi raccolti già negli anni ’70 e anche ultimamente convergono su un abbandono precipitoso della città, tanto da lasciarvi oggetti di valore e le scorte di metalli preziosi a disposizione degli artigiani. Una fuga che non si spiega con un evento lento come il bradisismo, bensì con un cataclisma improvviso e molto distruttivo. Come un’eruzione vulcanica, probabilmente una di quelle del Rotaro. Tesi che ha trovato conforto anche nel parere dei vulcanologi, sempre più spesso coinvolti in un’azione interdisciplinare durante i recenti scavi archeologici compiuti sull’isola.
Ma la storia di Aenaria ha ancora molto da rivelare. E scavi e studi non sono ancora finiti. Intanto, già ad ottobre dovrebbe essere inaugurato il Museo civico, costola del Museo di Pithecusae, che sarà allocato al primo piano della Torre di Guevara, con tutti i reperti frutti degli scavi del nuovo millennio. Quelli rinvenuti negli anni ’70 sono già esposti a Villa Arbusto.