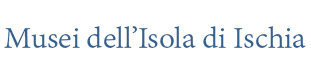Per una volta la parola evento non si è dimostrata eccessiva nè sovradimensionata. L’incontro di oggi alla Sala Poa dedicato a “IL CASTELLO ARAGONESE SOPRA E SOTTO IL MARE”, con il suo approccio multidisciplinare, ha confermato in pieno tutte le aspettative suscitate dall’interesse dei punti di vista utilizzati – geologico, biologico marino, archeologico e storico-antropologico – e dal valore dei relatori. Che ottimamente coordinati dal giornalista scientifico e scrittore PIETRO GRECO, hanno offerto un affresco ricco e appassionante della complessa realtà dell’isolotto, accompagnandolo con aggiornamenti importanti riguardo ai numerosi campi della ricerca ancora aperti. E tutti di rilevanza internazionale e destinati a riservare parecchi sviluppi nel futuro, anche prossimo.
Per una volta la parola evento non si è dimostrata eccessiva nè sovradimensionata. L’incontro di oggi alla Sala Poa dedicato a “IL CASTELLO ARAGONESE SOPRA E SOTTO IL MARE”, con il suo approccio multidisciplinare, ha confermato in pieno tutte le aspettative suscitate dall’interesse dei punti di vista utilizzati – geologico, biologico marino, archeologico e storico-antropologico – e dal valore dei relatori. Che ottimamente coordinati dal giornalista scientifico e scrittore PIETRO GRECO, hanno offerto un affresco ricco e appassionante della complessa realtà dell’isolotto, accompagnandolo con aggiornamenti importanti riguardo ai numerosi campi della ricerca ancora aperti. E tutti di rilevanza internazionale e destinati a riservare parecchi sviluppi nel futuro, anche prossimo.
LA GEOLOGIA
Ce n’era tanta di carne al fuoco, fin dalle premesse. E ancora di più ne è venuta fuori man mano che si sono succeduti gli interventi, tra i quali non son mancati collegamenti e scambi, rendendo ancora più avvincente il quadro complessivo che sono riusciti a ricomporre. Il viaggio è cominciato dalla storia geologica del Castello, tratteggiata esaurientemente da ANTONINO ITALIANO, che ne ha illustrato le caratteristiche come EDIFICIO VULCANICO attraverso una puntuale descrizione della stratigrafia che si rivela in modo evidente sulla parete di sud est. Dallo strato più basso, a contatto con il mare, formato da una lava molto compatta, sovrastata da un altro strato di lava dalla stessa composizione, ma meno compatta, che Rittmann aveva ribattezzato “azzechiti”.
Al di sopra di quella “base”, gli strati successivi corrispondono a episodi vulcanici diversi, comuni ad altre aree dell’area flegrea. Il primo è detto “formazione del Pignatiello” ed è formato da alcalitrachite: relativamente giovane, risale a 135-140mila anni fa. Poi c’è la “formazione del Canale d’Ischia”, lo stesso materiale piroclastico che si ritrova alle Formiche di Vivara, di 60-70mila anni fa; ancora sopra la “formazione Piano Liguori”, formata da ceneri vulcaniche sottili, il cosiddetto “maschione”, ancora più recente, del Paleolitico. Tuttavia, all’interno dell’isolotto di “maschione” non se ne trova, probabilmente perché fu utilizzato per costruire nel corso dei secoli.Sulla parete nord, poi, si nota il condotto vulcanico, prossimo alla cosiddetta “falsa scala”, che era l’antico strada di accesso al Castello e conduceva fin sul maschio.
Con la sua forma a pagnotta, caratteristica di lave ricche di silice dunque molto viscose, originariamente l’isolotto doveva essere un cono vulcanico. Una metà del quale dovette sprofondare pressappoco dov’è il ponte oggi. In quella parte dell’edificio vulcanico si sono aperte delle fratture, attraverso le quali i gas vulcanici vengono in superficie, provocando la formazione dei cosiddetti VENTS, di cui si stanno occupando i biologi marini per studiare gli effetti potenziali del cambiamento climatico.
Ma di cambiamenti climatici naturali se ne sono registrati tanti nella storia, con variazioni nel livello del mare. Quando vi fu l’eruzione che diede vita all’edificio vulcanico del Castello, 135mila anni fa, durante una glaciazione, il mare si trovava ben 11o metri al di sotto di oggi. Poi, nel periodo interglaciale, salì fino ad un picco massimo mai più emulato, oltre 7 metri più in alto di oggi. In seguito, con la glaciazione successiva si abbassò di nuovo. In quella fase vi fu l’eruzione del Canale d’Ischia. Nei periodi glaciali, con il mare più basso, sia Capri che le Isole flegree erano collegate alla terraferma come penisole, mentre sono state isole durante i periodi interglaciali.
LA RICERCA SULL’ACIDIFICAZIONE DEI MARI
 Delle conseguenze del cambiamento climatico che si sta cercando di arginare con l’accordo di Parigi siglato dei giorni scorsi, ha trattato la relazione di CRISTINA GAMBI del Laboratorio di Ecologia del Benthos. Alcuni effetti, come i fenomeni climatici estremi, sono già realtà attuale e condizionano più del passato anche i collegamenti invernali tra l’isola e il continente. E l’innalzamento delle temperature è testimoniato dallo spostamento dell’isoterma invernale (15°), che passava per Ischia, verso nord, oltre le Pontine. E l’acidità del mare già cresciuta del 26 per cento, dovrebbe ulteriormente aumentare fino a decuplicare il tasso registrato in 55 milioni di anni. Proprio questo è il problema: un incremento delle temperature e dell’acidità indotto dall’uomo e dunque molto più accelerato, tanto da rendere difficile l’adattamento delle specie viventi.
Delle conseguenze del cambiamento climatico che si sta cercando di arginare con l’accordo di Parigi siglato dei giorni scorsi, ha trattato la relazione di CRISTINA GAMBI del Laboratorio di Ecologia del Benthos. Alcuni effetti, come i fenomeni climatici estremi, sono già realtà attuale e condizionano più del passato anche i collegamenti invernali tra l’isola e il continente. E l’innalzamento delle temperature è testimoniato dallo spostamento dell’isoterma invernale (15°), che passava per Ischia, verso nord, oltre le Pontine. E l’acidità del mare già cresciuta del 26 per cento, dovrebbe ulteriormente aumentare fino a decuplicare il tasso registrato in 55 milioni di anni. Proprio questo è il problema: un incremento delle temperature e dell’acidità indotto dall’uomo e dunque molto più accelerato, tanto da rendere difficile l’adattamento delle specie viventi.
Il PH marino è di 8,1. Quando è al di sotto, più acido, produce degli effetti a catena a livello di composizione chimico-fisica dell’acqua, che la rende più corrosiva e meno ricca del carbonato di calcio, fondamentale per la struttura di vari organismi marini, che soffrono due volte. Nel sito presente sotto il Castello, dove si registrano emissioni di anidride carbonica, l’acqua – a parità di temperatura – è più acida che nelle zone circostanti con un PH 7,8, che è pari a quello previsto per il futuro degli oceani. Perciò quel sito è stato ed è studiato da ricercatori di ogni parte del mondo, tra i luoghi più seguiti e monitorati del pianeta.
I gas che originano dalla camera magmatica sottostante fuoriescono dalle fratture del fondale e risalgono a 1800-2000 anni fa. Almeno lì dove sono più forti, mentre in un altro sito, sono più recenti avvistate solo a partire dagli anni Novanta. Le zone dalle emissioni più forti, più acidificate presentano meno biodiversità e un paesaggio più uniforme. In quest’area si sta studiando la reazione delle varie specie animali, vegetali, algali al livello di acidità e ha trovato conferma l’ipotesi che il Ph 7,4 sia la soglia critica per varie specie: il 74 per cento non sopravvive in quelle condizioni. Nel laboratorio naturale sotto il Castello si stanno approfondendo le caratteristiche delle specie che sopravvivono in ambiente acido e quelle dei “perdenti” che vi rischiano l’estinzione.
Ma nella zona acidificata c’è anche una parte della prateria di Posidonia. E lì si nota che solo gli epifiti soffrono, mentre la fauna associata sopravvive senza troppi problemi. E la Posidonia non mostra diradamenti nè tanto meno regressione. Dunque, grazie alla fotosintesi, la Posidonia riesce a catturare la CO2 e fare argine all’acidificazione. Perciò le praterie di Posidonia, già tanto preziose per gli equilibri marini, sono essenziali per mitigare le conseguenza nefaste del cambiamento climatico: la stessa funzione svolta a terra dalle foreste.
Gambi ha poi illustrato il progetto finanziato dal National Geographic con la ricerca sugli altri 4 siti con emissioni di CO2. Siti che fanno di Ischia il principale laboratorio naturale al modo per lo studio dell’acidificazione di mari e oceani.
LE SCOPERTE SU AENARIA
Speculare al ruolo di primo piano che Ischia riveste oggi nella ricerca scientifica sui cambiamenti climatici è quello che si è conquistata anche sul fronte della ricerca archeologica, con le campagne di scavo nella baia di Sant’Anna in questi ultimi anni.
La storia della scoperta di Aenaria, iniziata nei primi Anni Settanta e poi interrotta per quarant’anni, è stata ricostruita dalla responsabile della Sovrintendenza per le isole e l’area flegrea COSTANZA GIALANELLA. Che ha presentato i reperti recuperati in quel primo periodo di esplorazione, condotto senza i mezzi e le specializzazioni in campo oggi, che sono esposti presso il museo di Villa Arbusto.
Delle scoperte di questi ultimi anni ha parlato l’archeologa ALESSANDRA BENINI, che guida lo scavo condotto insieme ai giovani di Marina di Sant’Anna. con il supporto delle immagini subacquee, Benini ha segnalato le tre aree nella baia dove sono state rinvenute testimonianze archeologiche: la zona portuale della città romana; le strutture residenziali riconducibili ad una villa marittima e la scogliera sommersa sotto il Castello.
La scoperta più sorprendente riguarda il porto, di cui è stata riportata alla luce la banchina. Ma il reperto fondamentale è la cassaforma lignea, approntata per ampliare la banchina mai ultimata. Della struttura di legno, realizzata con un’accuratezza e una capacità ingegneristica straordinarie, è stato finora recuperato un tratto di 20 metri, fino ad una profondità di ben 1,60 e si dovrà proseguire per scavare il resto. Già adesso, per le dimensioni, le caratteristiche e lo stato di conservazione (ottimo dopo duemila anni), quella ritrovata a Ischia è la cassaforma lignea più grande e importante mai trovata nel Mediterraneo.
Grazie all’individuazione della banchina e della cassaforma è possibile tentare una ricostruzione della linea di costa, che in età romana era certamente molto più avanzata. Così come il mare era più discosto dal Castello, come dimostra il molo angioino riportato alla luce proprio sotto l’isolotto. Dall’età romana ad oggi il livello del mare si è alzato di circa 7 metri.
Gialanella ha poi illustrato i reperti recuperati: anfore di varie provenienze; ceramica di età repubblicana a vernice nera, ceramica di importazione orientale, balsamari e oggetti della villa collocata sotto la chiesetta; migliaia di tessere di mosaico; ceramica da mensa in quantità; grossi quantitativi di galena; frammenti di cornici di marmo e una colonna.
Questi reperti saranno esposti al primo piano della Torre, dove si aprirà in primavera l’atteso museo, per il quale è arrivato finalmente l’atteso via libera del Comune, con approvazione anche del regolamento.
LA STORIA E I MITI
Per quanto è antica quella dei resti ritrovati sui fondali della baia, la storia del Castello è invece moderna, almeno nelle sue fasi più significative. A ricostruirla è stato l’antropologo UGO VUOSO, che è partito da Alfonso il Magnanimo artefice delle opere che hanno cambiato volto all’isolotto, facendone un castello in grado di svolgere un ruolo strategico, più volte sfruttato per controllare il golfo e conquistare o riconquistare Napoli. E al periodo di Alfonso appartiene anche l’insediamento (forzato) di truppe catalane sull’isola. Peraltro, il periodo aragonese fu il più fiorente, di massimo splendore per la rocca, dove si costituirono anche importanti cenacoli culturali.
Vuoso ha poi ripercorso i due secoli sotto il controllo dei D’Avalos, finiti nel 1739 che rappresentò una svolta per il Castello e per l’isola, che si affrancò da quel dominio. Poi arrivò la lenta, inesorabile decadenza, conclusa con il bombardamento del 1809, che ridusse il maniero in macerie. Poi il bagno penale di epoca borbonica e la concessione dei terreni in affitto, che trasformerà l’isolotto a fine ’800 in un’area vitivinicola, in linea con l’economia prevalente sull’isola grande. Fino alla vendita nel 1912 all’avvocato Nicola Mattera. Il Castello comincerà solo decenni ad affermarsi come luogo turistico, mentre il suo recupero e rilancio anche culturale è ancora più recente.
Vuoso si è anche soffermato sui miti del Castello, sulle rovine che evocavano il passato in modo inquietante, sugli spiriti da cui si riteneva fosse popolato, sulle leggende e i racconti fantastici che ha ispirato. Una realtà unica anche in questo, l’Insula Minor. Straordinaria e affascinante in ogni suo aspetto. Il simbolo/sintesi dell’isola d’Ischia.