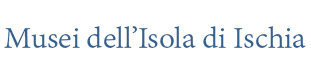Era stato proprio grazie ai “cocci”  che, dopo diciotto secoli di oblio, Aenaria aveva rivelato la propria esistenza sotto la sabbia e la rigogliosa prateria di Posidonia della baia di Sant’Anna, all’inizio degli anni Settanta dello secolo scorso. I sub che avevano scoperto la città scomparsa, durante una immersione si erano imbattuti in alcuni oggetti ceramici che, portati a terra e sottoposti alla valutazione di esperti, erano risultati di origine romana, aprendo così la strada ad una prima esplorazione del fondale, alla ricerca di altre testimonianze antiche. Dopo quarant’anni, le nuove ricerche condotte in quello stesso sito dal 2011 hanno consentito di recuperare ancora un gran numero di reperti di terracotta, confermando che l’eredità di Aenaria già tornata alla luce è composta in gran parte proprio di oggetti ceramici. Il che è abbastanza normale nella maggior parte dei siti archeologici. Ciò che è particolare a Ischia e che si può considerare come il filo rosso che lega le testimonianze di epoche e di civiltà diverse è non solo e non tanto la presenza di terrecotte, perdipiù di vari stili e provenienze, ma piuttosto l’esistenza di centri di produzione locali. Un particolare che fa della nostra isola un “unicum” nel Mediterraneo, anche rispetto alla stessa Grecia.
che, dopo diciotto secoli di oblio, Aenaria aveva rivelato la propria esistenza sotto la sabbia e la rigogliosa prateria di Posidonia della baia di Sant’Anna, all’inizio degli anni Settanta dello secolo scorso. I sub che avevano scoperto la città scomparsa, durante una immersione si erano imbattuti in alcuni oggetti ceramici che, portati a terra e sottoposti alla valutazione di esperti, erano risultati di origine romana, aprendo così la strada ad una prima esplorazione del fondale, alla ricerca di altre testimonianze antiche. Dopo quarant’anni, le nuove ricerche condotte in quello stesso sito dal 2011 hanno consentito di recuperare ancora un gran numero di reperti di terracotta, confermando che l’eredità di Aenaria già tornata alla luce è composta in gran parte proprio di oggetti ceramici. Il che è abbastanza normale nella maggior parte dei siti archeologici. Ciò che è particolare a Ischia e che si può considerare come il filo rosso che lega le testimonianze di epoche e di civiltà diverse è non solo e non tanto la presenza di terrecotte, perdipiù di vari stili e provenienze, ma piuttosto l’esistenza di centri di produzione locali. Un particolare che fa della nostra isola un “unicum” nel Mediterraneo, anche rispetto alla stessa Grecia.
Neppure nella terra di provenienza dei coloni fondatori della Magna Grecia, infatti, sono state ritrovate realtà archeolgiche assimilabili a quanto è riemerso dalle viscere della terra a Lacco Ameno, a partire dai primi anni Cinquanta. Al di sotto della piazza di Santa Restituta, gli omonimi scavi hanno rivelato, grazie all’opera di don Pietro Monti, la presenza di artigiani ceramisti fin dagli albori dell’insediamento nell’VIII. E, d’altronde, è da Pithecusa che la tecnica più avanzata di lavorazione della terracotta, ovvero l’uso del tornio, si diffuse tra le popolazioni italiche che prima non conoscevano. E a Lacco Ameno sono state trovate e sono ancora visibili e fruibili al pubblico le fornaci pithecusane, usate senza soluzione di continuità per vari secoli, fino all’età ellenistica. Un patrimonio unico, che è stato oggetto qualche anno fa di una specifica ricerca condotta dall’Università di Berlino su tutti i centri di produzione artigianale dell’antichità nel Mare Nostrum, e che individuò in Ischia l’unico esempio di fornaci giunte fino ai nostri giorni. Perdipiù, con uno straordinario corredo di materiali, scarti di produzione, bolli dei vasai, oggetti ancora in preparazione, oltre ai prodotti finiti.
Ebbene, se i vasai pithecusani, che esportavano i loro prodotti in tutto il bacino mediterraneo, furono attivi dall’VIII secolo a.C. fino all’età ellenistica a Lacco Ameno, sull’altro versante dell’isola, ad Aenaria, in epoca romana, vi erano parimenti delle botteghe di ceramisti dalle quali uscirono buona parte dei “cocci” riportati alla luce dagli scavi di quarant’anni fa ed esposti in parte nel Museo Archeologico di Pithecusae.
Anche per Aenaria a rivelare la presenza in loco di botteghe di ceramisti è stato il recupero di alcuni scarti di produzione. In particolare dei tegoli malamente cotti, tra i quali ne fu individuato uno che recava impressa la lettera E, probabilmente una sorta di bollo, che poi era la “firma” dei vasai, secondo un’usanza largamente diffusa proprio a Pithecusa.
I fondali della baia avevano restituito anche una ceramica dal caratteristico color verde oliva, classificata come Campana C, perché presenta delle variazioni particolari rispetto alla più nota Campana B, a cominciare da una verniciatura nerastra con un bollo a losanga. Elementi che hanno portato gli esperti a definirla come “Carta Romana”, databile intorno al 130 a.C. Dunque, esiste una sorta di sottogruppo della ceramica Campana B che è riconducibile specificamente alla nostra isola, dove sono stati trovati anche quantitativi importanti di prodotti figulini importati da Pozzuoli, altra città in cui l’attività dei vasai era fiorente in periodo augusteo, ma anche molta ceramica aretina. E i bolli hanno fatto giungere fino a noi i nomi di un tale Sexto Tito, che operava forse proprio al di là del mare, a Pozzuoli appunto, e di un certo Memmio, che invece era vasaio ad Arezzo. Una traccia interessante degli scambi commerciali del tempo così come i bolli delle ceramiche pithecusane hanno consentito di conoscere i flussi commerciali da e verso l’isola con gli altri porti del Mediterraneo. Notizie e ricostruzioni a cui di certo verrà un grande contributo dallo studio dei tanti oggetti di terracotta raccolti nelle ultime campagne di scavo a Cartaromana. Custoditi come gli altri reperti di Pithecusa nella Torre di Sant’Anna, dove, quando Aenaria sarà stata completamente disvelata, dovrebbe essere allestito uno spazio espositivo tutto dedicato ai reperti dell’antica città romana.